
Introduzione
E’ veramente difficile sopravvalutare il ruolo che le scienze della vita avranno negli scenari futuri dell’economia mondiale e dei nuovi sistemi di salute.
Le scienze della vita costituiscono la più importante e completa piattaforma di convergenza fra scienza fondamentale, aggregazione tecnologica (sono trainano anche di grandi sviluppi scientifici e tecnologici dell’informatica, della chimica, dell’automazione, della fisica e così via), organizzazione dei sistemi di cura e personalizzazione dell’assistenza.
Se si esamina il dibattito internazionale l’Italia appare in grave ritardo.
La questione più importante è che tale ritardo non deriva principalmente dalla “normale medietà” di risorse umane scientifiche, tecnologiche e produttive, che possono essere disponibili per un paese di media taglia come l’Italia: è cioè normale che l’Italia non sia sulla frontiera più avanzata in qualcuno dei molti segmenti della filiera che va dalla scienza fondamentale alle terapie, se non in casi episodici. E questo benchè anche piccoli paesi come quelli scandinavi o l’Irlanda possano vantare prestazioni di assoluta eccellenza in qualche segmento.
La gravità del ritardo riguarda in primo luogo l’attenzione politico-istituzionale e le strategie di governance.
Per comprendere questo punto è sufficiente una succinta comparazione con un paese molto affine all’Italia come la Francia.
Tale paese è dotato di un certo vantaggio strutturale sull’Italia soprattutto sui segmenti della catena del valore che vanno dalla ricerca fondamentale, allo sviluppo (sperimentazione clinica), alla produzione, in particolare dei farmaci.
Per esempio, la Francia è leader mondiale della ricerca oncologica, ha un “campione nazionale” come Sanofi-Aventis (fra le più importanti multinazionali della farmaceutica mondiale) nella produzione di farmaci, è certamente messa meglio dell’Italia nelle biotecnologie.
Ma il punto chiave è che a partire almeno dal 2004 la Francia è impegnata in una riflessione strategica ai massimi livelli di governo e in interventi strutturali per riattivare la capacità attrattiva di investimenti, se non altro per non perdere terreno in comparti chiave della filiera.
In Italia invece si assiste ad una specie di deriva inconsapevole in cui gli attori della filiera (sanità, produzione, ricerca) continuano a viaggiare per conto proprio e in cui l’unico strumento vero di convergenza coatta è il taglio della spesa sanitaria.
Il rischio di entrare in circoli viziosi a medio e lungo periodo sono molto elevati.
Alcuni elementi di analisi sono necessari per dare corpo a queste considerazioni e per fornire una guida sia pure minima in questa materia straordinariamente complessa.
Le grandi componenti delle “life sciences”: la farmaceutica
Tradizionalmente si potevano riassumere le “life sciences” e i loro impieghi diretti per la terapia umana (a cui aggiungere gli impieghi nell’alimentazione e nell’ecologia) in due comparti principali: la produzione, articolata in farmaceutica e biomedicale; la diagnostica, la cura, la riabilitazione organizzata dalle istituzioni sanitarie.
A tutt’oggi, gli attori in gioco appaiono ancora modellati secondo questa articolazione, in quanto soggetti autonomi dotati di logiche indipendenti.
Le cose sono tuttavia molto cambiate e richiedono una riarticolazione fine delle catene relazionali, soprattutto in vista dei loro profondi mutamenti.
Data la complessità della questione e la multipolarità dei “focus” innovativi conviene costruire delle sottocatene componenti.
Cominciamo dal rapporto fra ricerca e produzione, prendendo come esempio la farmaceutica.
Fino a non molti anni fa si era consolidato un sistema di rapporti centrato sulla grande impresa (le cosiddette “big pharma”).
La ricerca di base era essenzialmente di tipo “chimico” e consisteva per lo più in una immane quantità di esperimenti in cui si cercava alla cieca di accoppiare molecole chimiche e bersagli patologici.
In queste condizioni erano necessarie grandi economie di scala nella ricerca perché si trattava di metodi di massa alla cieca: una specie di fordismo della ricerca.
In particolare, non era necessario per tale tipo di ricerca avvalersi della ricerca accademica.
Questa condizione fordista era ulteriormente corroborata dalle economie di scala necessarie alle altre fasi che portavano alla produzione.
A valle della ricerca di base sta infatti lo sviluppo, che nella farmaceutica consiste in una serie di operazioni di sviluppo preclinico e di sviluppo clinico (4 fasi di sviluppo clinico).
Si tratta in sostanza di sottoporre molecole promettenti a sperimentazioni di laboratorio e poi, via via, ad esperimenti sugli animali e a vari tipi di esperimenti su campioni umani.
La fase di sperimentazione clinica è assolutamente cruciale soprattutto perché mette in contatto le imprese farmaceutiche con gli ospedali che partecipano alla sperimentazione.
Anche la fase di sviluppo richiedeva (e richiede) ingenti mezzi finanziari e organizzativi.
Una volta ottenuta l’approvazione alla messa sul mercato del farmaco, la produzione si effettua in alcune fasi principali.
Innanzitutto la produzione del principio attivo. Si tratta di una operazione ad alto livello tecnologico e con relativamente pochi impianti a livello mondiale.
In secondo luogo la formulazione del farmaco, cioè la sua costruzione in quanto somministrabile all’uomo e il suo confezionamento. Poi la logistica distributiva.
Man mano che si va dalla fabbricazione del principio attivo al confezionamento, i vincoli di localizzazione degli impianti (prossimità a risorse critiche) tendono ad allentarsi.
Tuttavia il vincolo di prossimità ai mercati importanti rimane comunque alto per quanto riguarda lo sviluppo clinico e l’accessibilità alle reti distributive capillari.
In particolare lo sviluppo clinico richiede che il farmaco sia sperimentato in rete anche nei luoghi che sono mercati promettenti: si tratta insomma anche di una sorta di marketing, dato che i clinici che vi partecipano con risultati positivi diventano automaticamente testimonials cruciali.
Questo modello da qualche tempo ha cominciato ad essere sconvolto a partire dalla fase di ricerca.
Già negli ultimi decenni si assisteva ad una produttività decrescente nella scoperta di nuove molecole: sempre meno molecole, con costi di sviluppo sempre più elevati, anche in ragione del rigore crescente richiesto nelle sperimentazioni.
Inoltre emergeva un altro problema per le “big pharma”: la diminuzione delle nuove molecole brevettabili faceva sì che non si potesse più compensare la perdita del controllo sui farmaci dovuta alla scadenza dei brevetti, con la conseguente apparizione di sempre più importati mercati dei “generici” (e di produttori anche di paesi non occidentali, come l’India).
Contemporaneamente, si assisteva all’avvento delle biotecnologie, sia pure con fasi di grandi speranze e di parziali delusioni.
Il problema è che i modelli di ricerca biotecnologici sono molto diversi dai modelli classici.
Innanzitutto si parte dalla scienza fondamentale e perciò la ricerca universitaria ha un ruolo dominante.
In secondo luogo i laboratori di ricerca possono essere anche di piccola taglia, sia pure con un tasso di fallimento molto elevato.
Tutto ciò deriva dalla sostituzione del “paradigma di ricerca chimico” con il “paradigma di ricerca biotecnologico”.
Quest’ultimo paradigma non sperimenta alla cieca una enorme quantità di combinazioni fra molecole e bersagli.
Esso si struttura come “rational drug design”:
· si costituiscono, in base alle conoscenze scientifiche di biologia molecolare e cellulare, insiemi di possibili bersagli (per esempio, proteine responsabili di malfunzionamenti patologici);
· in base ai bersagli si progettano famiglie di molecole promettenti (tramite la chimica combinatoria) e le si fa interagire con i bersagli (tramite la selezione ad alta capacità, attuata con robot).
L’aggregazione di competenze biologiche, di bioingegneria, di chimica, di trattamento dei dati e delle immagini, supportata da macchinari sofisticati, diviene lo strumento chiave.
Partendo da basi genetiche, le biotecnologie offrono infine un panorama applicativo molto più ampio (oggi si stima che su 18.000 patologie conosciute, 12.000 non abbiano antidoti adeguati) e che presenta prospettive di crescente personalizzazione delle cure.
La reazione delle big pharma si è sviluppata in diverse direzioni.
Da un lato si è assistito a un processo di concentrazione “classica”: di dimensioni gigantesche appaiono, ad esempio, l’acquisizione della svedese Pharmacia da parte dell’americana Pfizer e le fusioni che hanno creato l’anglo-svedese AstraZeneca, la svizzera Novartis, la francese Sanofi-Aventis.
D’altro lato, si è aperto un processo marcatamente postfordista di creazioni di reti estese e complesse di relazioni, in particolare fra big pharma e imprese biotech: acquisizioni, cooperazioni, finanziamenti a rischio, licenze e così via.
Tali reti hanno interessato in modo cruciale anche centri di ricerca, università, ospedali …
Il caso più appariscente è stato quello della svizzera Roche, che ha acquisito la numero due mondiale del biotech, l’americana Genentech.
In Italia la Novartis, acquistando la californiana Chiron, ha acquisito l’importante centro di ricerca sui vaccini localizzato a Siena, attorno al quale si è costituito recentemente il polo biotech sostenuto dal Monte dei Paschi.
Uno dei motori fondamentali dello sviluppo a rete è che, tipicamente, le imprese biotech non riescono ancora a raggiungere una dimensione sufficiente per controllare gli altri anelli della catena e quindi una qualche forma di partnership è comunque necessaria nello sviluppo clinico, nella produzione, nella commercializzazione.
Tuttavia anche queste fasi dovrebbero conoscere rivolgimenti profondi, in particolare per quanto riguarda i nuovi vantaggi competitivi delle localizzazioni.
Infatti in un contesto di strategia-paese è importante distinguere le diverse fasi, perché ciascuna di esse è sottoposta a vantaggi localizzativi differenti.
Un altro aspetto cruciale del cambiamento del paradigma è dato dal rapporto fra sperimentazione, produzione farmacologica e modelli terapeutici.
A partire dalla sperimentazione clinica effettuata negli ospedali (per iniziativa propria o su richiesta delle imprese), si entra più strutturalmente nel mondo sanitario.
E’ plausibile ritenere che il cambiamento di paradigma inciderà profondamente sugli assetti attuali, che prevedono la giustapposizione fra mondo delle imprese e mondo sanitario.
Si può ipotizzare intanto che verrà rafforzata la tendenza all’emergere di reti di ospedali di eccellenza ad alto contenuto di ricerca e connesse a livello mondiale.
Ciò metterà in movimento l’architettura generale della rete ospedaliera.
In secondo luogo è possibile che le applicazioni estratte dal nuovo paradigma trainato dal biotech, possano interessare anche la sanità territoriale (ambulatori specialistici, home care,) e il ruolo del medico di base.
In terzo luogo le stesse strutture che supportano le terapie saranno interessate da profondi cambiamenti organizzativi e professionali.
Le grandi componenti delle “life sciences”: il biomedicale
Il riferimento alle strutture ospedale/sanità territoriale e all’organizzazione terapeutica ricongiunge il settore farmaceutico al settore biomedicale.
Sotto il profilo politico le associazioni del settore biomedicale marcano la loro differenza con il settore farmaceutico, sia in Italia che in Europa.
Un elemento chiave di distinzione riguarda la sperimentazione: rigorosamente formulata per il farmaco, opaca per il biomedicale.
Il problema non è la brevettazione o la certificazione di qualità (con i relativi aspetti clinici) dei dispositivi biomedicali. La questione riguarda semmai l’ammissibilità al rimborso da parte del sistema di assicurazione sanitaria pubblica.
E qui le cose prendono una piega per così dire “pragmatica”.
Mentre per quanto riguarda dispositivi di grande impatto innovativo, come per esempio gli ecografi, i servizi sanitari nazionali concedono senza dubbi l’acquisto pubblico, più incerta è la situazione per dispositivi a contenuto innovativo di tipo incrementale.
Ne risulta una grande frammentazione dei mercati sia fra i 25 paesi dell’Unione, che a livello regionale.
Peraltro le imprese biomedicali temono una regolamentazione rigida perché quella esistente in campo farmaceutico è minuziosissima e si basa su sperimentazioni cliniche che possono durare più di 10 anni.
Naturalmente non sarebbe comunque questo il caso per i prodotti biomedicali che, a differenza dei farmaci, interferiscono con la fisiologia umana in modo per lo più (non sempre) trascurabile.
Il settore biomedicale è vastissimo e con tecnologie molto differenziate (dai cerotti alla telemedicina) e quindi è più difficile rintracciarne logiche di trasformazione comparabili con quelle farmaceutiche.
Peraltro il biomedicale è pervasivo e onnipresente in ogni microsegmento del ciclo.
Non è dunque possibile darne qui una illustrazione.
Si può accennare alle questioni di maggiore impatto sociale.
L’invecchiamento della popolazione cambia i pesi relativi delle patologie e apre spazi crescenti di mercato anche al biomedicale. In certi stati europei la spesa per dispositivi sorpassa quella per i farmaci.
Per esempio, riguardo alle malattie cardiovascolari, una importante innovazione è stata quella degli Stent coronarici, dispositivi impiantabili che allargano le arterie del muscolo cardiaco ostruite.
Un altro esempio è la pompa a insulina: un minuscolo apparecchio portatile che somministra continuamente insulina ai diabetici secondo un programma prestabilito.
Funzionante 24 ore su 24, essa richiede una ricarica che può durare fino a tre giorni e sostituisce le iniezioni praticate parecchie volte al giorno, con benefici aggiuntivi in termini di prevenzione di complicazioni a lungo termine della malattia.
Al polo opposto, un esempio può riguardare la profilassi per Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), ancora oggi causa principale di mortalità infantile per patologie respiratorie nei paesi occidentali, nei bambini prematuri, da 0 a 2 anni cardiopatici o broncodisplasici.
Di natura “sistemica” è invece l’immenso comparto in evoluzione della telemedicina.
Essa spazia dalla telesorveglianza alla telechirurgia e alle operazioni medico-chirurgiche assistite da computers, ai dossiers medici condivisi.
La telemedicina offre grandi prospettive in particolare per i servizi di mantenimento a domicilio di persone anziane o di persone affette da malattie croniche con un bisogno importante di attività logistica.
Questa breve panoramica degli aspetti economici e scientifico-tecnologici che ruotano intorno alle prestazioni di salute porta a una conclusione chiara: è in atto una gigantesca convergenza scientifico-tecnologica (farmaceutica, biotech, biomedicale) su piattaforme aperte in infinite direzioni evolutive che combinano i saperi più disparati e ricreano nicchie di mercato.
Del resto molte delle principali multinazionali del farmaco, come soprattutto le americane Abbott e Jhonson & Jhonson, ma anche Pfizer e così via, sono ampiamente presenti nel biomedicale, oltre che nel biotech.
Da questo breve tratteggio dell’universo delle “life sciences” si può trarre una morale.
Si tratta del più importante ed esteso capitolo dell’economia della conoscenza, sia dal punto di vista delle scienze e delle tecnologie implicate, sia da quello del fine, cioè la salute umana.
Non solo, ma il cambiamento è su un fronte vastissimo, è profondo e avviene a velocità impressionante.
Che fare di fronte a ciò?
La reazione più semplice potrebbe essere quella di individuare politiche che incentivino la rincorsa in ciascun segmento separatamente inteso.
Ciò non è possibile. Per esempio le fabbriche dei principi attivi farmacologici sono poche, richiedono la prossimità di centri di ricerca specializzati e vengono disegnate e localizzate con anni di anticipo rispetto alla stessa approvazione per la commercializzazione.
Attualmente, la riduzione di molecole approvate negli ultimi anni comporta un forte sottoutilizzo degli impianti.
L’unica prospettiva promettente, ma anche necessitata, è quella di presidiare il complesso della catena del valore dalla ricerca fondamentale alle organizzazioni diagnostico-terapeutico-riabilitative territoriali.
Si tratta cioè di mantenere in piedi intanto un intero sistema di apprendimento, anche se in gran parte si tratta di semplice assorbimento di risultati altrui.
Cenni sul posizionamento dell’Italia
In estrema sintesi si può intanto osservare che l’Italia è un mercato di taglia media, ma evoluto e appetibile.
Liquidiamo subito una fonte di infinite polemiche: in Italia il consumo pro-capite di farmaci e la loro quota sulla spesa sanitaria sono fra i più bassi in Europa.
La sanità italiana, almeno nel centro-nord, è di notevole livello.
La situazione peggiora sul versante ricerca-produzione.
La bilancia commerciale è negativa intorno ai 4 miliardi di Euro, equamente ripartiti fra farmaceutica e biomedicale.
Per di più questo sbilancio deriva interamente dai comparti a maggior contenuto tecnologico, come la produzione dei principi attivi e il macchinario biomedicale, essendo gli altri comparti eccedentari.
Manca un campione nazionale della farmaceutica, anche se è decisamente importante la presenza di medie e piccole multinazionali italiane di alta qualità e di sedi e impianti delle maggiori multinazionali estere.
Infine è nota la presenza di uno dei più consistenti cluster biomedicali mondiali nel mirandolese ed importante la presenza di imprese di apparecchiature come la genovese Esaote.
Il settore biotecnologico è ancora quasi inesistente.
E’ improponibile per un paese come l’Italia rimanere tagliata fuori da qualche segmento della catena del valore farmaceutica, biotecnologica, biomedicale.
Non è solo questione di vantaggio competitivo, ma è questione di costruzione e acquisizione di conoscenze che mantengano l’Italia ad un alto livello di prestazioni di salute.
E’ impensabile che possiamo cavarcela con i vantaggi comparati: vendiamo Armani e compriamo terapie biotech.
Stare dentro a tutta la catena vuol dire avere tutti i canali di apprendimento: saper parlare il linguaggio delle scienze fondamentali, giù giù fino alla prevenzione e alla cura ambulatoriale e casalinga dei malati in ogni parte del territorio.
A parte questa esigenza di base e a parte la possibilità di eccellere in qualche segmento, la competitività italiana va coltivata secondo le linee che sono emerse negli ultimi 40 anni.
L’esempio dei distretti industriali è importante, anche se non ci si può attendere una normale evoluzione.
Le fortune dei distretti si sono basate sulla capacità di autorganizzazione di sistemi imprenditoriali localizzati, che acquisivano e rigeneravano per lo più tecnologie importate.
Questo è il luogo primario della specialità italiana.
Il campo delle “life sciences” è infinito: ibridare conoscenze anche importate (ciò che comunque richiede un ambiente capace di esplorare, leggere e capire), generare nicchie di mercato.
Il terreno delle conoscenze da ibridare non si limita alle competenze biologiche, ma investe ogni campo del sapere tecnico (informatica, elettronica, meccanica, chimica, ecc).
A questo punto è necessario fare un po’ di ordine e strutturare una gerarchia di potenzialità di intervento che sia politicamente spendibile.
Una piattaforma solida e nevralgica: la sperimentazione clinica
Si è detto della centralità dello sviluppo clinico.
Del suo essere perno tra ricerca, applicazione e diffusione di conoscenza.
Tra apprendimento e momento organizzativo anche terapeutico. Soprattutto in relazione alle possibilità aperte dalle biotecnologie e, come si è accennato, anche all’integrazione, nel settore biomedicale, con le esigenze tecnologiche che si profilano all’orizzonte.
In Italia, lo sviluppo clinico segue la progressiva rarefazione della nascita di nuove molecole. Si svolgono per la gran parte studi di fase III e IIIb, relative a farmaci comunque già noti o a loro varianti. Anche se si stanno comunque svolgendo studi di grande importanza relativi a nuovi farmaci di natura biotech, soprattutto nel settore oncologico.
La persistenza, già sottolineata, di segmenti di eccellenza nella ricerca e in molte strutture ospedaliere, dotate anche di buone infrastrutture, fornisce una piattaforma iniziale da sfruttare per costruire e sostenere reti di poli di eccellenza per lo sviluppo clinico legato alle nuove tecnologie.
Uno dei primi, necessari passi da affrontare consisterà nell’indispensabile snellimento degli ostacoli burocratici che ancora appesantiscono i percorsi della sperimentazione clinica nel nostro paese, soprattutto a livello amministrativo. E nell’osservazione e registrazione meticolosa di tutto quanto ne ostacola il percorso di applicazione: dai tempi della stesura dei contratti alle risorse da fornire per accrescere le sperimentazioni spontanee.
Come peraltro già richiesto e promosso sia dall’AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) sia dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità).
Quanto detto fin qui riguarda le fasi che portano alla registrazione del farmaco e dispositivi e alla loro eventuale ammissibilità al rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Esistono però altre fasi di sperimentazione, che coinvolgono principalmente le Regioni, in particolare per quanto riguarda l’analisi costi/benefici nella prescrizione di farmaci, dispositivi biomedicali, profilassi, nuove modalità di cura, etc.
Questa situazione attualmente produce una disparità di scelte da Regione a Regione.
E’ opportuno dunque valutare la possibilità di incentivare specificamente queste fasi e di approntare i canali per la diffusione dei best practices.
L’eccellenza dello sviluppo clinico in Italia deve quindi diventare un momento di maggiore e qualificata visibilità internazionale ed europea.
Senza un suo potenziamento al massimo livello sarà molto difficile operare le integrazioni di conoscenza, di promozione e sostegno allo sviluppo tecnologico e produttivo di cui si è parlato in questo documento.
Aprire altri varchi
Ovviamente, non è pensabile di potere ottenere successi significativi puntando sulla sola sperimentazione clinica.
Oggi in Italia negli ospedali prevale l’incentivo derivante dall’acquisizione di risorse finanziarie di cui la sanità ha una autentica fame ed eventualmente dalla crescita dei guadagni personali dei clinici.
Bisogna aprire altri fronti che facciano capire che, oltre ai benefici finanziari al sistema sanitario e alla possibilità di curare i malati in modo più aggiornato, qui si tratta di politica industriale strategica, indispensabile anche per la prevenzione e la migliore cura dei malati.
Si può qui accennare ad altri punti di attacco, tenendo conto che il pacchetto di interventi deve anche contenere proposte rapidamente attuabili.
Elencando in ordine decrescente di complessità realizzativa:
· seguire la linea dei poli di competitività francesi, applicata a partire dal 2006. Rimandando alla nota specifica sul tema, qui si sottolinea come l’idea di lavorare alla costruzione di clusters territoriali (impresa, ricerca, enti pubblici) abbia una particolare pertinenza al caso italiano, alla sua capacità di autoorganizzazione e si presta anche a sperimentazioni nel Meridione;
· incentivare la costruzione di segmenti di filiera. Esistono potenziali di connessione fra competenze anche prossime territorialmente, ma che spesso senza un importante intervento esterno non sono in grado di connettersi in termini di autoorganizzazione;
· incentivare la collaborazione scientifico-tecnologica fra imprese, anche piccole, e centri di ricerca. Normalmente questi due mondi sono separati da abissi di linguaggio e interesse, ma nelle “life sciences” queste distanze si riducono drasticamente.
Lavorare sul territorio, immettere enzimi che facilitino le ibridazioni di conoscenza consente altresì di generare informazione rilevante (ed eventualmente da organizzare) anche per settori apparentemente distanti: meccanica, tessile, arredamento, agroalimentare e quant’altro.
Non bisogna infatti trascurare che i processi di ibridazione avvengono continuamente e quindi già oggi ci troviamo grandi cambiamenti negli assetti cognitivi che originarono i distretti “classici”.
(Ricerca fatta da Patrizia Beccari; Alberto Corazza, Tito Casali)



















































































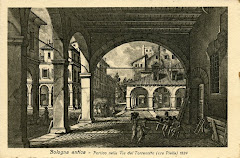
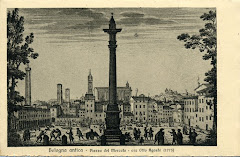













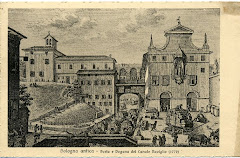





Nessun commento:
Posta un commento